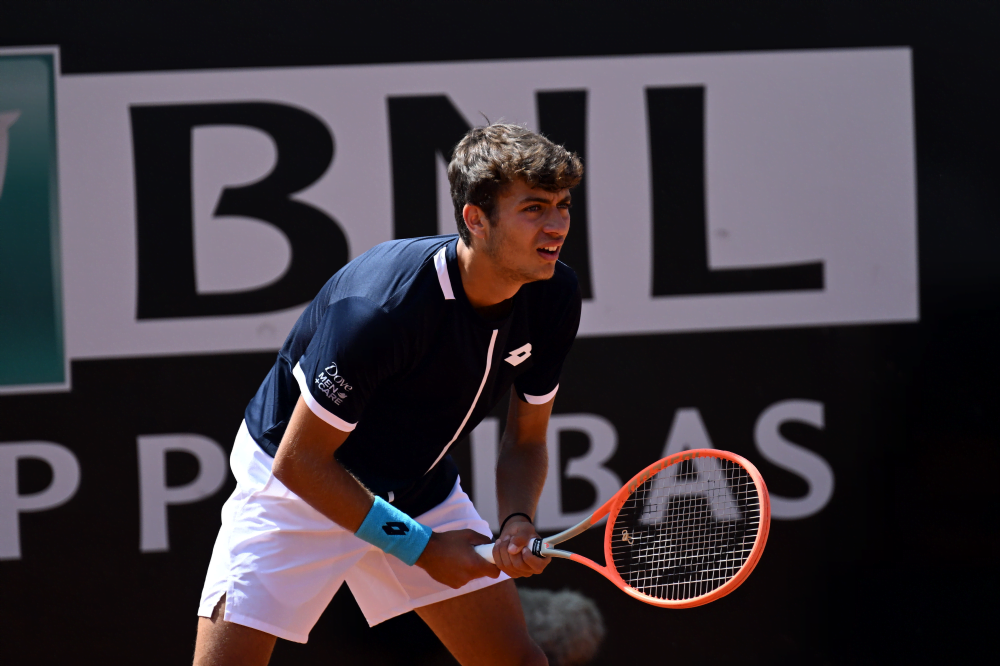La nostra ultima intervista con la leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli, scomparso in queste ore, pubblicata sul numero di maggio giugno 2025 de Il Tennis Italiano

Anche i campioni del tennis piangono, soprattutto quelli ai quali è sfuggito Wimbledon, lo slam degli slam. Non sei grande davvero se non hai indossato almeno una volta il mantello della leggenda. È successo, per esempio, a Ken Rosewall, quattro volte finalista, Ilie Nastase, due volte finalista, Guillermo Vilas, Ivan Lendl, due volte finalista, Andy Roddick, tre volte in finale e tre volte battuto da Federer. È successo anche a Nicola Pietrangeli ed è stata una sofferenza non da poco.
Dunque, ci troviamo con Nicola a parlare di cosa doveva essere e non è stato, per vedere l’effetto che fa. Non siamo nessuno, senza un passato, gli dico a mo’ di premessa. Bisogna accettarlo, dice Pietrangeli, con le sue meraviglie e i suoi orrori, senza sentirsi per forza colpevoli. L’ultima volta ci eravamo incontrati davanti a un piatto di bollito misto alla piemontese. Manzo e gallina, lingua e testina, cotechino, patate e sedano. Uno dei suoi preferiti. Parlammo della prima Davis italiana conquistata senza fatica nel 1976 a Santiago del Cile contro una squadra di gran lunga inferiore a Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli. Quattro chiodi storti pieni di talento, difetti di carattere e voglia di vincere e di vivere.
Quella volta però non era solo tennis. «La politica cercò di fermarci, ma io volevo andare laggiù per battere, per umiliare Pinochet. Alla fine convinsi pure Enrico Berlinguer. Partimmo scortati dai carabinieri, al ritorno invece degli applausi volarono pomodori. Uno sfregio che superammo nello spazio di una notte». Nessun rimpianto, dunque? Sbagliato. La Davis mi ha procurato molte ferite. Non è possibile. Intanto è suo il record mondiale di presenze in Coppa, 164 in maglia azzurra con 120 vittorie. Numeri testimoni di una grandezza. Ma non l’ho mai vinta da giocatore, la Davis. È, mi creda, un rimpianto enorme. Eppoi c’è il modo che ancor mi offende con il quale sono stato liquidato da capitano, dopo due finali consecutive. Ha capito bene? Consecutive.
Abbandonato anche dai suoi ragazzi? Le buone azioni non restano mai impunite. Mi invitarono in una camera d’albergo. Impacciati e tremebondi. Diglielo tu, no tocca a te. Seguì un lungo silenzio, fino a quando Bertolucci si fece forza. Non ti vogliamo più, questa la sintesi del suo discorso. Infilai la porta e addio. Il tempo ha poi levigato i rancori. Li ho perdonati, ma non dimentico. Volevo però parlare soprattutto di Wimbledon. Che cosa è stato per lei? Qualsiasi bambino tennista desidera vincere Wimbledon. Se ci pensa è un sogno banale. Quel torneo è diabolico, ti scivola via dalle mani quando sei convinto di averlo tutto per te. Una cicatrice beffarda, ecco che cosa è stato.
Lei ha partecipato a diciannove edizioni, dal 1954 al 1973. È in grado di condensare i ricordi in una sola parola? Gioia. Che cosa contiene la parola che ha scelto? Non solo fragole e panna, ma la Londra del dopo guerra, il fervore degli anni Sessanta, la rivoluzione dei costumi, donne bellissime e emancipate, la gioventù da godere fino all’ultimo respiro. Un carpe diem che ci sembrava infinito, fino a quando a smentirci arrivarono gli anni Settanta… E l’erba di Wimbledon? Infida, ti obbligava a servizio e volée. Compito difficile soprattutto per noi europei specialisti della terra. Quasi sempre si sbarcava a Wimbledon dopo aver giocato la Davis sul rosso a Varsavia o a Praga. Partite al limite dei cinque set. Se eri fortunato e riuscivi a iscriverti al Queen’s un po’ di allenamento lo facevi, in caso contrario nei primi turni dei Championships pareva di giocare sul ghiaccio.
Il suo debutto nel singolare maschile risale al 1954. Venne battuto al primo turno dal britannico George Godsell in tre set: 6-3 6-1 6-2. Non lo ricordo. Ero convinto di aver perso da Vic Seixas, che poi si sarebbe aggiudicato il titolo. Mi sbagliavo. La grande occasione arriva nel 1960. Lei ha ventisette anni, è all’apice della carriera, considerato dai giornali americani e inglesi il numero due o tre al mondo. In semifinale l’attende Rod Laver, detto Rocket per la sua velocità. Ha 22 anni, è una sorta di cowboy australiano con le efelidi di un irlandese. Che cosa sapeva di lui? Lo chiamavo, per rispetto, il Signor Laver. Mancino, aveva un polso di ferro allenato in maniera specifica per consentirgli colpi e recuperi da incredibile incontrista. Avrebbe voluto vincere sempre 6-0 6-0 6-0. Esisteva qualcuno in grado di batterlo? Lew Hoad, in rare occasioni. Hoad era un altro australiano prodigio, sul piano tecnico senza pari, purtroppo discontinuo. Ricorda come si preparò a quella semifinale? Un po’ di tennis leggero, non ero un grande lavoratore. E una chiacchierata con il mio amico Gianni Clerici, che voleva sapere se intendevo accettare la corte di Jack Kramer e passare tra i professionisti. Io avevo ben altri pensieri per la testa. “Mi sposo vecchio mio”, gli dissi, “e vorrei vincere il torneo, è ora di diventare uomini”.
Laver non sembrava affatto fiducioso. Il favorito è Nicola, disse ai giornalisti nelle ore della vigilia. Non fu una partita di tennis, fu una guerra. Laver vinse al quinto set: 4-6 6-3 8-10 6-2 6-4. Che cosa accadde? Sul quattro pari al quinto, dopo aver fatto una partita difensiva, e io mai avevo giocato così bene sotto rete, Laver riaccese il suo genio e si prese in un lampo gli ultimi due game. Dimostrò semplicemente di essere il migliore, capace di prodezze di tocco ancora oggi ineguagliabili. Disse: Nicola non meritava di perdere. Solo un gesto di buona educazione? Credo lo pensasse davvero. Un anno dopo giocammo la rivincita agli Internazionali d’Italia che si tennero a Torino. Lo superai in quattro set ma ci fu lotta solo nel primo che Rod si aggiudicò otto a sei, nei successivi tre gli lasciai appena quattro game. Un successo spietato che però non guarì i rimpianti di Wimbledon.
Le statistiche dicono che lei ha conquistato 48 titoli, 687 vittorie e 278 sconfitte, con un saldo positivo del 71,19 per cento. Al di là dei numeri che cos’è per lei il tennis? Lo sport dei pazzi e dei solitari. Peggio (o meglio) dell’amore? In me sono stati alla pari, ma gli amori mi hanno fatto più male nel momento in cui sono finiti. Ho amato quattro donne meravigliose. Susanna, madre dei nostri tre figli, Lorenza, Licia e Paola. Sono state loro a lasciarmi, per mille ragioni, per le troppe delusioni, chiamiamole così… Ero un cacciatore, ora sono uno scapolo vecchio e malinconico.
Colpa delle miscele complicate che scorrono nel suo sangue? Forse sì. Madre russa di stirpe nobiliare, padre italiano, nonno paterno tedesco, nonna svedese. Insomma, sono un bel bastardo. Lei è stato becchino, commerciante di magliette Lacoste, calciatore, tennista, consulente pubblicitario, attore e presentatore televisivo. C’è un mestiere che ha inseguito vanamente? L’esploratore, seduto sulla schiena di un elefante. Mi è sempre piaciuto viaggiare e ho pensato a lungo che con il tennis non sarei andato più lontano di Milano. Torni indietro nel tempo e cambi la sua vita. Il gioco non mi piace, la rifarei da capo con tutte le mie frescacce e i miei dolori. Solo un deficiente può dire di essere privo di rimpianti. Ho vissuto la vita così come mi è stata data, a piene mani. E come si vive a novant’anni? Tra cose belle e cose brutte, penso molto all’ultimo atto e provo sensazioni che non riesco a descriverle. E guardi che gli anni sono novantadue. Gianni Clerici definì lei e Adriano Panatta “i nostri due narcisi”. Aveva ragione? Credo proprio di sì.